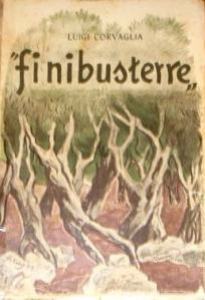FINIBUSTERRE: RITRATTO DI UN SALENTO DIMENTICATO
di Alessio Stefàno
«Maestro,
sono un solitario, a cui, in questi anni di smarrimenti, la sua parola è valsa di conforto e di conferma. Per dirle la mia gratitudine, le dedico un romanzo che le invio a parte, un libro non gaio, nel quale il dramma è quello stesso del restare uomini».
È il testo di una lettera, datata al giugno 1936, scritta da Luigi Corvaglia, filosofo e scrittore nato a Melissano nel 1892.
Il destinatario della lettera non è un uomo qualunque ma il più grande filosofo italiano del Novecento: Benedetto Croce. Gli “anni di smarrimenti” a cui il mittente fa riferimento sono quelli del Regime fascista. Erano passati appena undici anni da quel 1° maggio 1925, quando il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” del quale lo stesso Benedetto Croce si era fatto promotore, sancì la definitiva rottura del filosofo napoletano e di numerosi altri intellettuali italiani col regime, contro le pericolose deviazioni verso le quali questo si stava avviando.
 libro autografo di Luigi Corvaglia, esposto in occasione della mostra a Melissano sul Vanini, a cura di Dario Acquaviva (su gentile segnalazione di Stefano Cortese)
libro autografo di Luigi Corvaglia, esposto in occasione della mostra a Melissano sul Vanini, a cura di Dario Acquaviva (su gentile segnalazione di Stefano Cortese)
La produzione letteraria del Corvaglia è molto vasta e comprende alcune commedie come La casa di Seneca (1926), Rondini (1928), Tantalo (1929), S. Teresa ed Alonzo (1931), così come intensa è la sua attività di ricerca sul pensiero filosofico naturalistico-rinascimentale del Vanini e dello Scaligero (E. Gaballo, 2010).
Ma il romanzo che l’autore invia al suo Maestro è uno scritto di tutt’altra natura. Il suo titolo è semplice ed evocativo: Finibusterre.
Benedetto Croce, dopo aver letto con piacere il libro, apprezzò notevolmente «lo sfondo storico rappresentato in modo assai vigoroso» e il «trattamento dei caratteri e degli affetti» (Lettera del 30 ottobre 1936).
La vicenda romanzesca si svolge nella prima metà dell’Ottocento, entro uno sfondo storico di miserevoli avvenimenti. I signorotti locali sono pronti a garantirsi, in ogni modo, il privilegio di sfruttare, nelle terre del Capo – dove dominano fatica silenziosa, ignoranza e malaria – una vasta folla di uomini inermi. Donato Valli descrive questo romanzo come un «sondaggio nel corpo della civiltà salentina, donde scaturirà la prima dolorosa consapevolezza della condizione di ultima frontiera non solo geografica ma anche spirituale» (D. Valli 1999, p. 214).
Ecco così che, già nelle prime pagine del romanzo, emerge l’immagine di quel Salento per noi (forse) sconosciuto e dimenticato:
«Entro la malia […] di un mare di turchese è disteso il Capo, scheletro gigantesco. Lo spazza il vento e lo dilava la pioggia; la roccia calva si trascina carponi al mare. Le spiagge flagellate e rose, s’estendono entro una luce violenta che le illumina senz’ombre. In questo spiazzo si muovono gli uomini, assorti, lenti, come seguendo il ritmo intimo di questa monotonia. Parlano sottovoce o urlano, ma il loro vero linguaggio è ruminazione silenziosa.
La lingua è aspra, cupa, povera d’immagini, virile, quasi ieratica, ancora latina ed ellenica in buona parte. Sorridono di rado. Il riso è spasmo. Cantano nenie, ove, dallo sfondo d’infinito divino e inutile, tornano le nostalgie di remoti nomadismi e d’indefinibili aspettazioni. Tono d’anima un grigiore cipiglioso.
Vivono in povertà, senza lirismi. Un frusto di pan d’orzo li sfama. Pan di grano è sinonimo di viatico. Il bisogno ha spenta in loro ogni vivezza. La lotta secolare con la terra e coi turcheschi li ha fatti chiusi, sospettosi, ma nel tempo stesso energici e insensibili alle sofferenze. La vita è fatica uguale, in cui l’uomo dura senza gemiti, nel gran mare del mondo, con le poche cose fatte da lui e dai suoi e che perciò son sue: casa, terra, donna, figli, ch’egli difende da un mondo di nemici… Tutto è qui: fatica e istinti, donde un concetto squallido delle ragioni del vivere. Dallo sfibramento dell’esperienza la riflessione cava la trama di lividi moralismi: Tutto passa. Siamo portati dal destino. In fondo la morte» (L. Corvaglia, Finibusterre, 1936, pp. X-XI).
È in questa cornice, tetro affresco di parole, che si muovono silenziosi gli attori di una storia già scritta dal destino. I personaggi del Corvaglia sono gli umili: Piero e Maria, Diascane e Maddalena, Anna e Lisa e tutta la massa dei contadini e dei pastori, «protagonisti rassegnati di una storia senza eroismi e senza gloria». Ciò che muove questa massa, sfruttata da potenti nobili e dai malviventi che vivono al loro seguito, è una sorta di istinto comune: «la fame, implacabile come un destino, tragica livellatrice dei sentimenti a un passo dall’ultima consunzione». È così che «ogni fantasia, ogni speranza, ogni progetto, ogni anelito di bontà finiscono con l’impastarsi in quella terribile concretezza di uno stomaco vuoto, che annulla le differenze e tutto unifica in universale gemito di dolore» (D. Valli 1999, pp. 225-226).
La storia ha inizio dalla costa Ionica del Salento Meridionale; ma i luoghi appaiono ben diversi da quelli che oggi conosciamo:
«Pietro scendeva con la mandria verso la palude. S’era levata nell’aria una frescura fumosa di puntini di nebbia, che odoravan d’arsiccio. Diafana dappresso, diveniva poco più innanzi compatta, sino a nasconder l’orizzonte tutt’intorno. Il sole s’affacciava smorto dalla cresta della Serra, dietro una cortina di nuvole che ora s’univano, ora si sfrangiavano. Fasci improvvisi di luce assaettavano il terreno, rinverdendo la macchia» (L. Corvaglia, Finibusterre, cit., pp. 14-15).
Un paesaggio tetro e piatto, costellato di macchie insidiose e di fetide paludi, dove ogni estate «la caldura […] prometteva un risveglio più grave della malaria» (ivi, p. 49). Un paesaggio del quale si può avere immediata contezza andando ad osservare la cartografia storica.
Cartografia del Rizzi – Zannoni (1812). Dettaglio della porzione della costa ionica del Capo di Leuca da Torre San Giovanni (Ugento) a Torre Vado (Morciano di Leuca). Si notino, in particolare, le caratterizzazioni delle varie aree Paludose e Macchiose, oggi non più esistenti a seguito degli interventi di bonifica conclusi nel secondo quarto del Novecento.
Ma la palude – così come il bosco – è anche il luogo del soprannaturale, delle apparizioni, porta verso mondi lontani e sconosciuti. È qui che il deforme mandriano Dòmine – «una larva d’uomo» – in una cappella diruta e dimenticata, improvvisamente – quasi in uno stato di trance – incomincia a cantare «un’antica nenia salentina, lenta, lieve, dolce, che parea venire da lontananze». È un canto interiore, liberatorio; «si sviluppava enarmonico, come se montasse tra mille anfratti, dapprima più rumore che suono, poi si fissava chiaro, in accordo con un misterioso diapason interiore». In quegli attimi «lo sguardo dello storpio si illuminava. Affiorava l’uomo mancato, l’altra personalità, di cui l’ordinaria era una deviazione». Ma l’uomo cantava nella rassegnazione che «il male sarebbe tornato tante volte sino all’ultima» (ivi, pp. 17-18).
È così che, dalla penna di Luigi Corvaglia, si presenta al lettore – quasi trent’anni prima di Ernesto de Martino – la terra del cattivo passato che ritorna e del rimorso, chiavi di lettura del dolore delle Tarantate: «noi oggi sappiamo che il “pungolo” non è l’assalto di un demone o di un dio, ma il cattivo passato che ritorna e che si ripropone alla scelta mondana riparatrice» (E. de Martino, p. 300). Il morso simbolico del ragno viene presentato come ri-morso di un episodio critico del passato, di un conflitto rimasto senza scelta, che l’etnologo può osservare sul campo (E. Imbriani, 2018, p. 85). In senso più ampio l’intera Italia meridionale, l’antico Regno di Napoli, è terra del rimorso, cioè del «cattivo passato che torna e rigurgita e opprime col suo rigurgito» (E. de Martino, 2013 [1961], p. 35; E. Imbriani, 2018, p. 85).
E nel romanzo del Corvaglia non poteva mancare un capitolo dedicato al Tarantismo: «Tarantola pronuba». Protagonista del morso è la povera Lisa, la quale «una mattina non aveva potuto abbandonare il letto». Ella, volgendo inerme lo sguardo verso il soffitto, osservava tra le travature «una esile ragnatela». I simboli erano lì, pronti ad agire nell’inconscio della fanciulla: la tela, il ragno, San Paolo… Alla fine «presa dalla vertigine, s’abbandonò a qualcosa di oscuro emerso dagli abissi della sua vita, e chiuse gli occhi» (Finibusterre, cit., pp. 284-285).
Copertina della prima edizione del romanzo (fonte: https://www.fondazioneterradotranto.it/2011/01/13/il-salento-nella-produzione-letteraria-di-luigi-corvaglia-melissano-1892-roma-1966/)
Di quella terra, al Corvaglia, lo affascinano ancora i miti, la storia, le vestigia d’un passato lontano, che il tempo, l’incuria e l’indifferenza vanno lentamente sbriciolando (C. Micolano 1982, p. 88). Il disegno della copertina del romanzo – un bosco d’ulivi contorti – venne affidato alla mano di «un altro tenace indagatore dell’archetipo salentino», Vincenzo Ciardo, il quale «in quegli anni approfondiva le ricerche del suo paesaggio di terra riarsa e di sassi luminosi, di ulivi tormentati e di silenzi tragici» (D. Valli 1999, p. 214). Quegli stessi ulivi del quale il Corvaglia ci racconta la mitica origine:
«Tempi remoti. Un giorno le ninfe intrecciavan danze. Sopraggiunse Méliso, pastore che aveva umore ridanciano e prese a dileggiarle con versacci. Le ninfe, irritate, gli si fecero intorno come vespe, lo toccò la prima: Fatato! Le ganasce si fecero rigide, legnose. Lo toccò la seconda, poi la terza, la quarta…Da tocco a tocco le gambe divennero radici, penetrarono nel terreno, il tronco morto, scorza dura, le braccia, rame d’oleastro ove l’anima restò prigioniera. Figli di Méliso furono i polloni dell’albero. La pianta ebbe frutti, semi, si diffuse. Passarono molti anni. Una delle ninfe, impietosita, tolse la magia. Ma Méliso era già secco. Anche nella maggior parte degli olivastri, suoi figlioli, l’anima si era fatta legnosa e non poterono nascere in forma d’uomini. I pochi che tornarono alla vita non riacquistaron quasi più l’abitudine del sorriso, così intima rimase in loro la natura dell’ulivo» (Finibusterre, cit., pp. 226-227).
L’ulivo diventa anche immagine dell’anima della popolazione salentina: «in esso geme una fatica d’esistere che non ha pari se non nel paesaggio corroso e drammatico delle serre aggettanti sul mare» (D. Valli 1999, p. 215).
Ma l’anima dei salentini è fatta anche di pietra. Ce lo ricorda don Paolo Santacroce, uno dei personaggi più interessanti del romanzo, enigmatico penitenziere del santuario di Santa Maria a Finibus Terrae: «Il signore per dar forma all’anima salentina scelse la pietra. Dalla roccia veniamo e vi torniamo. Pietra siamo» (Finibusterre, cit., p. 228).
Bianca è la pietra del Salento, quella che diede il nome all’ultimo promontorio che si affaccia ripido sul mare: Leuca, λευκός (leukòs). E su questo bianco promontorio si affaccia il Santuario, un tempo ultimo baluardo della civiltà e della cristianità, proteso verso il mare e l’infinito. L’austera chiesa, «attraverso feritoie e finestrottole […] occhieggiava ostile verso ponente. Un piombatoio era posto a dominio del portone del vestibolo, in fondo al quale s’intravedeva la porta del tempio. Un’ala di fabbricati ferrigni continuava quella cupezza a sinistra». «Sull’orlo del promontorio» – dove oggi svetta l’alto faro – «s’elevava tozza massiccia la torre dei guardacoste». Era qui che si assolvevano i peccati più gravi ed era qui che «i più grandi assassini vi avevano trovata la pace».
È a Finibusterre che tutti tornano: «chi non ci va da vivo ci ha da andar da morto» (Finibusterre, cit., pp. 203-204).
© Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte dell’autore, è vietata.
BIBLIOGRAFIA:
- Corvaglia, Finibusterre, Edizioni dell’Iride, 2006 [I ed. 1936]
- de Martino, La terra del rimorso, Il saggiatore, Milano, 2013 [I ed. 1961]
- Gaballo, Il Salento nella produzione letteraria di Luigi Corvaglia, «Spiciliegia Sallentina», n. 7, 2010
- Imbriani (a c. di), Il peso dei rimorsi. Ernesto de Martino cinquant’anni dopo, Milella, Lecce, 2018
- Micolano, Finibusterre, romanzo storico di Luigi Corvaglia: una rievocazione del Salento all’inizio del secolo scorso, «Contributi», anno I, n. 2, Giugno 1982
- Valli, Il dio ignoto. Lettura del romanzo Finibusterre di Luigi Corvaglia, in D. Valli (a c. di), Aria di casa. Cronache di cultura militante, Serie II, Tomo I, 1999